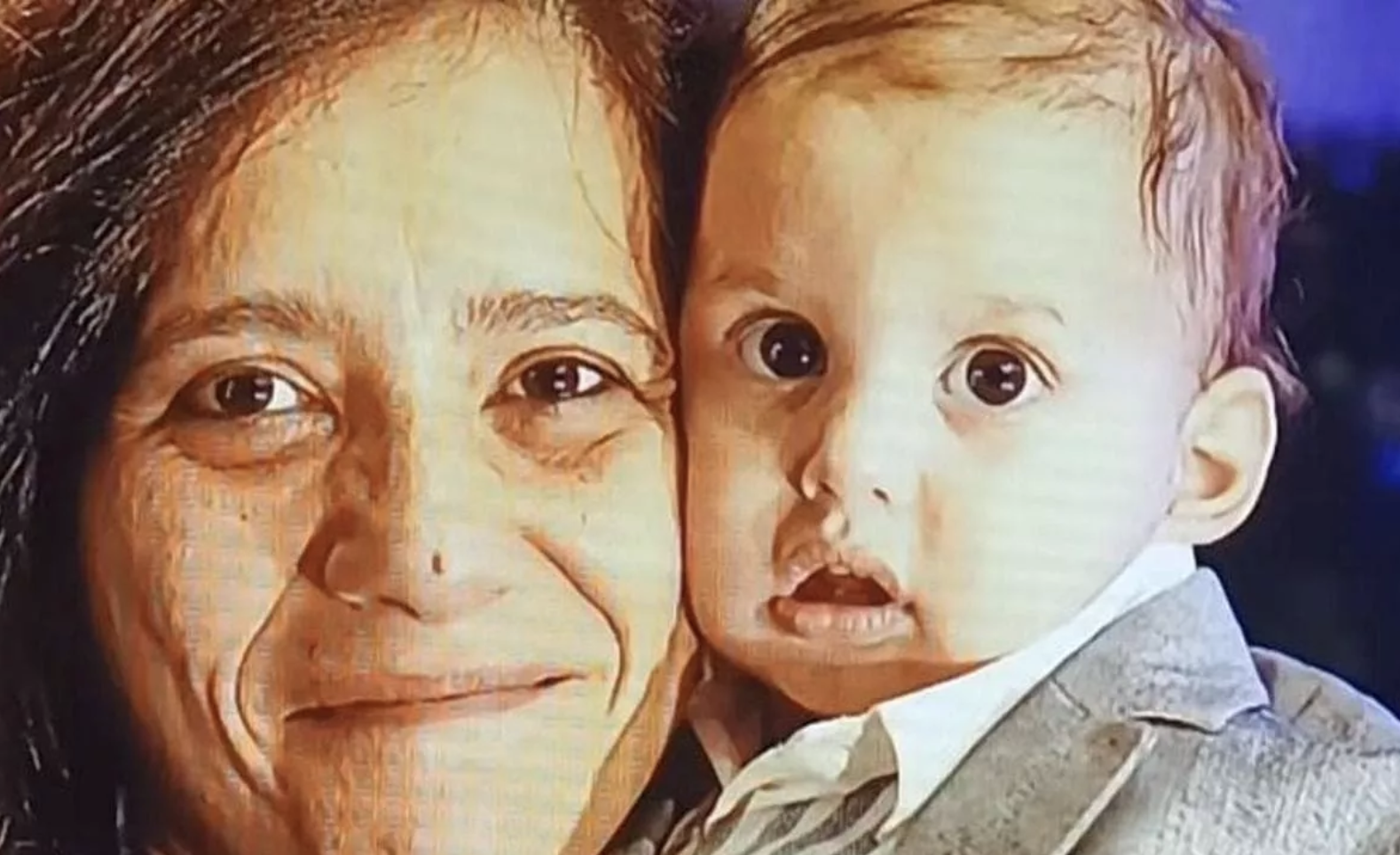di Emma Conti
Viviamo in un’epoca in cui siamo costantemente connessi. Lo smartphone ci accompagna ovunque, i social ci danno l’illusione di una rete infinita di contatti, le piattaforme digitali promettono relazioni rapide e senza confini. Eppure, mai come oggi, l’essere umano sperimenta la solitudine come condizione diffusa, cronica, quasi strutturale. La definiscono “l’epidemia silenziosa” e non è un’esagerazione. Nel 2023 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha creato una Commissione dedicata alla connessione sociale, riconoscendo l’isolamento come una minaccia globale per la salute pubblica, comparabile all’obesità o all’alcolismo.
L’allarme non nasce oggi. In Giappone, già dagli anni Novanta, il fenomeno degli hikikomori aveva anticipato una fragilità che sarebbe diventata globale. Ragazzi che si rinchiudevano nelle proprie stanze per mesi, talvolta per anni, tagliando ogni rapporto con l’esterno. Non si trattava di ribellione, ma di ritiro, di una resa silenziosa. Il professor Tamaki Saitō lo studiò a fondo, intuendo che quegli adolescenti non erano semplicemente “pigri” o “immaturi”, ma testimoni di un disagio profondo: la difficoltà di sostenere la pressione sociale, la paura del fallimento, l’incapacità di costruire legami autentici.
Oggi gli hikikomori non sono più un fenomeno esclusivamente giapponese. L’Associazione Hikikomori Italia stima circa 120.000 casi nel nostro Paese, e dati simili emergono in Francia, in Spagna, negli Stati Uniti. Il ritiro sociale è diventato un sintomo di un malessere più ampio, che attraversa culture e continenti.
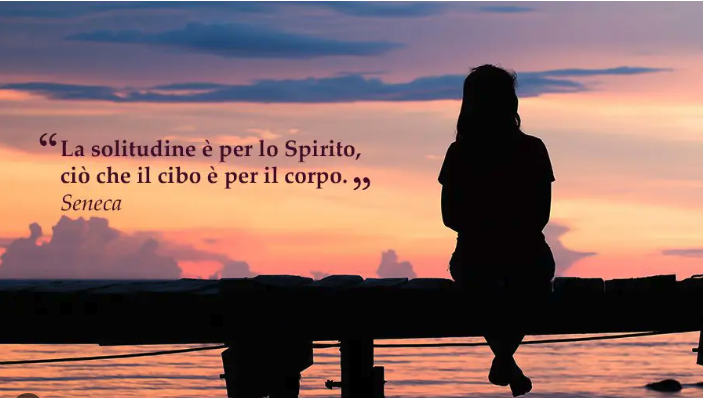
Le conseguenze non riguardano solo la sfera psicologica. Una meta-analisi di Julianne Holt-Lunstad, pubblicata su Perspectives on Psychological Science, ha dimostrato che la solitudine cronica aumenta il rischio di mortalità del 26 per cento. Tradotto: vivere isolati ha effetti sulla salute simili a quelli del fumo di quindici sigarette al giorno. Le neuroscienze aggiungono che il nostro cervello si è evoluto come organo sociale: è programmato per il contatto, per la relazione. Privato di connessione, reagisce con stress, depressione, calo delle difese immunitarie. È come se il corpo stesso ci dicesse che la solitudine è innaturale.
Ma c’è di più. La solitudine non si limita a corrodere l’individuo: intacca il tessuto sociale. Possiamo immaginare la società come un organismo complesso, in cui ciascun individuo è una cellula. Quando le cellule smettono di comunicare, l’organo si ammala. Così la frammentazione e la chiusura che sperimentiamo oggi non sono solo esperienze personali, ma il sintomo di una società in crisi.
Zygmunt Bauman definiva la nostra epoca “modernità liquida”, fatta di legami fragili, identità instabili, relazioni reversibili. In questo contesto l’individuo impara a fuggire: fugge dalla profondità, fugge dal rischio, fugge dalla fatica che comporta ogni rapporto autentico. Eppure, proprio quei legami complessi e duraturi sono ciò di cui abbiamo più bisogno.

Perché l’essere umano, in quanto creatura evoluta e complessa, non può accontentarsi di connessioni superficiali. Ha bisogno di costruire legami strutturati, solidi, capaci di sostenerlo. Quando questo viene a mancare, non ci chiudiamo solo agli altri: ci chiudiamo anche a noi stessi. La relazione, infatti, non è soltanto il luogo in cui ci raccontiamo, ma anche lo strumento attraverso cui impariamo a conoscerci. Come scriveva Erik Erikson, l’identità individuale si forma solo nell’incontro con l’altro. Senza interlocutori, non esploriamo più il nostro io, perdiamo il bisogno di indagare il nostro inconscio, ci impoveriamo moralmente e spiritualmente.
E allora ecco il paradosso: più ci isoliamo, più diventiamo incapaci di comprenderci. Più cerchiamo di proteggerci, più alimentiamo il vuoto che ci spaventa. È un circolo vizioso che lascia macerie invisibili ma profonde.
Di fronte a tutto questo, esiste una via d’uscita? Forse sì, ed è più antica di quanto pensiamo. È la fede. Non intesa solo come adesione a un credo religioso, ma come gesto di apertura radicale, come scelta di fidarsi, di condividere, di mettersi in relazione.
Nell’esperienza cristiana, la fede non è mai un atto solitario: è comunità, è ascolto, è portare la croce insieme. La fede ci richiama alla preghiera, alla riflessione, alla costruzione di valori condivisi. Non serve soltanto a noi stessi, ma ha senso solo se vissuta in rapporto con l’altro. Viktor Frankl, sopravvissuto ai campi di concentramento, lo scrisse con chiarezza: l’uomo ha bisogno di un orizzonte che vada oltre il proprio io, altrimenti precipita nel vuoto.
Per anni ci siamo chiesti come affrontare questa epidemia silenziosa. Abbiamo guardato alla tecnologia, alla psicologia, alla sociologia. Forse, però, la risposta è sempre stata davanti ai nostri occhi. Tornare alla fede come esperienza di comunità, di introspezione, di condivisione. Non si tratta solo di credere in Dio, ma anche di credere negli altri e nella vita.
La solitudine non è più una condizione privata: è un problema collettivo, un male sociale. E se è vero che la tecnologia ci ha regalato infinite connessioni virtuali, è altrettanto vero che ci ha tolto, spesso, la qualità del legame autentico.