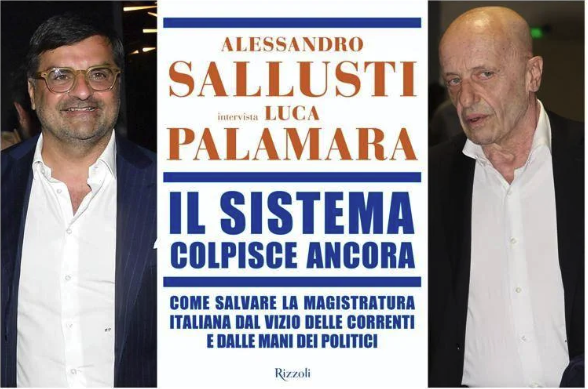di Emma Conti
Non sono le discussioni a far fallire i legami. Sono le fughe. Sono le scelte mancate. Ci sono rapporti che si dissolvono al primo soffio, e altri che resistono ai terremoti. La differenza sta nella disciplina: la capacità di scegliere, ogni giorno, di restare. Un legame non è un atto concluso, ma una decisione quotidiana. Soren Kierkegaard ci ricorda che la fede è mantenere saldo ciò che non si vede. È così anche per i rapporti: continuano a vivere non grazie all’assenza di conflitti, ma grazie alla volontà di attraversarli. La disciplina della scelta è ciò che dà sostanza al legame.
Viviamo però in un tempo in cui tutto sembra sostituibile: partner, amicizie, persino comunità. Al primo ostacolo, molliamo. Preferiamo l’illusione di un altrove più semplice alla fatica di restare. Così disimpariamo il senso della responsabilità, e rinunciamo alla possibilità di costruire. Ma se allarghiamo lo sguardo, vediamo che questo non riguarda solo le nostre vite private. È la stessa logica che condanna Gaza.
Dal 1948, con la Nakba, i palestinesi hanno conosciuto lo sradicamento. Da allora, la loro storia è un continuum di esodi, occupazioni, blocchi. Le Intifade hanno gridato al mondo il bisogno di dignità, mentre la risposta è stata violenza, repressione, nuovi muri. Gli Accordi di Oslo avevano promesso una strada, ma sono stati traditi dall’inerzia, dall’espansione degli insediamenti, dalla mancanza di coraggio politico.
Gaza è oggi una prigione a cielo aperto. Non un campo di battaglia tra eserciti, ma un luogo in cui milioni di civili sono intrappolati tra la logica delle armi e l’indifferenza internazionale. La discussione si è spenta, sostituita dalla forza. E la forza, come ricordava Hannah Arendt, non è mai politica: è solo la sua negazione.

Eppure, sotto le macerie, resiste una disciplina silenziosa. La madre che cucina, l’insegnante che continua le lezioni, il bambino che gioca tra le rovine: questi atti sono politica allo stato puro. Mahmoud Darwish lo disse con chiarezza: “Noi amiamo la vita quando la troviamo degna di essere vissuta”. In un luogo in cui la vita viene continuamente negata, il semplice gesto di viverla è un atto di resistenza.
Edward Said ci ha insegnato che la narrazione è potere: chi racconta, decide. Gaza viene raccontata troppo spesso come un problema, un conflitto, una minaccia. Ma Gaza è anche esseri umani che resistono alla cancellazione. Amin Maalouf ci avverte delle “identità assassine”: ridurre un popolo a un’etichetta significa negargli umanità. È ciò che accade ogni volta che un palestinese viene visto solo come terrorista, e ogni israeliano solo come occupante.
Non esistono legami senza riconoscere l’altro nella sua complessità. Senza questa scelta quotidiana, l’unica alternativa è la guerra infinita. Ecco il punto: Gaza non è solo un luogo lontano. È uno specchio. Ci interroga sulla nostra capacità di fedeltà, sul nostro coraggio di restare nei legami, di non fuggire al primo conflitto. Sartre ci ricordava che siamo condannati alla libertà: non possiamo evitare la responsabilità delle nostre scelte. Ogni giorno, a livello personale come politico, dobbiamo decidere se mollare o restare, se ridurre l’altro a nemico o riconoscerlo come interlocutore.

La violenza sembra più rapida, più semplice. Ma è illusione: genera solo macerie. La scelta vera, la scelta difficile, è quella della disciplina del legame. È quella che può trasformare discussioni in dialoghi, ferite in memoria condivisa, conflitti in convivenza. Per questo Gaza ci riguarda tutti. Perché se accettiamo che lì il legame venga spezzato, accettiamo che ovunque il mondo sia condannato a vivere di rapporti interrotti e guerre senza fine.
Il manifesto è chiaro: senza fedeltà al legame non c’è futuro. Né per noi, né per Gaza, né per il mondo.