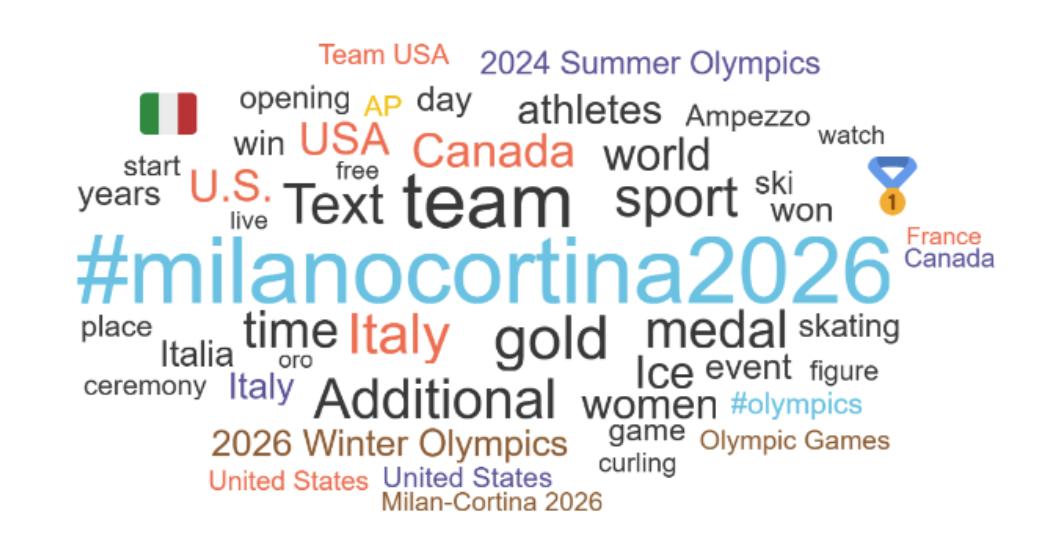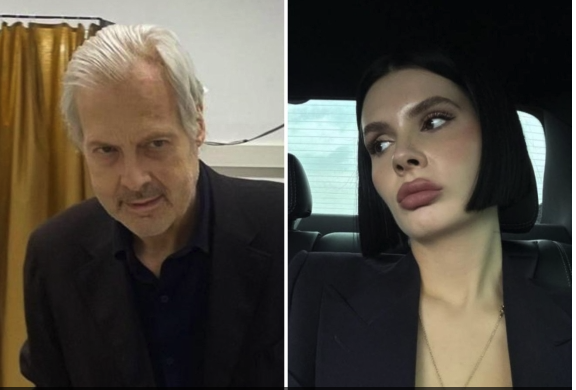Quattro governi di sinistra e altrettanti di destra, due referendum falliti e nessun risultato concreto nei 13 tentativi in quasi quarant’anni,.Sin dai tempi di Flick guardasigilli e D’Alema premier, arriva la sorpresa: il centrosinistra ci ha provato quanto il centrodestra, ma l’Associazione magistrati ha sempre bloccato ogni ipotesi di riforma, sempre allo stesso modo. Nei decenni a cambiare completamente è stata solo la fiducia dei cittadini che ritiene la giustizia lenta, “lottizzata” e sopratutto autoreferenziale ed impunita.
Ecco la ricostruzione degli ultimi 40 anni
1988, governo De Mita.
Il nuovo Codice Pisapia-Vassalli introduce il processo accusatorio e la prima distinzione tra pubblico ministero e giudice. Per la prima volta si distingue tra chi accusa e chi giudica: due ruoli, due logiche, due funzioni diverse che tuttavia vedono formare giudici e pm nello stesso corpo. Da allora a oggi si assiste al lento tentativo di far germogliare questa separazione nella Costituzione.
1996-1998, governo Prodi I.
Dopo gli sconquassi di “Mani pulite”, il guardasigilli Giovanni Maria Flick, cattolico, ex giudice di Cassazione e futuro presidente della Consulta, propone di separare le funzioni: vuole limitare i passaggi da una all’altra, differenziare formazione e avanzamento e riorganizzare il Csm in modo che eserciti una vigilanza distinta sui due ruoli. La prima proposta organica di “separazione funzionale” arriva quindi da sinistra, non da destra. L’associazione magistrati commenta come farà sempre nello stesso modo (ogni volta) e la critica sarà sempre la stessa: la riforma, dice e dirà, mina d’indipendenza della magistratura e vuole sottoporla all’esecutivo. La riforma di Flick comunque non viene approvata.
1997-1998, Bicamerale D’Alema.
La separazione delle carriere è discussa in chiave costituzionale. Tra i relatori più attivi c’è Marco Boato dei Verdi, che sostiene la necessità di distinguere nettamente le funzioni. Il progetto si arena insieme alla Bicamerale, ma il principio rimane agli atti parlamentari.
2000, governo Amato.
Un referendum radicale tenta l’abolizione dei passaggi tra funzioni nel tentativo di introdurre una separazione delle carriere dal basso: ma il quorum non viene raggiunto.
2004, governo Berlusconi II.
La prima versione della riforma di Roberto Castelli viene bocciata dal capo dello Stato (Carlo Azeglio Ciampi) per rischi di incostituzionalità. Il ministro leghista propone una riforma ampia dell’ordinamento, il rinvio resta il più pesante altolà istituzionale a una riforma della giustizia in tempi repubblicani.
2005, governo Berlusconi III.
La legge Castelli (separazione attenuata) prevede un solo passaggio entro 5 anni: i magistrati devono scegliere all’inizio della carriera le funzioni giudicanti o requirenti e possono cambiare solo una volta entro i primi cinque anni. È la riforma più incisiva mai realizzata, anche se non arriva alla separazione vera e propria.
2006, governi Berlusconi III e inizio Prodi II.
Servono i decreti attuativi per completare la riforma Castelli, la macchina è in moto, ma il sistema politico è già pronto a smontarla.
2007, governo Prodi II.
Cancellata la Castelli. La nuova legge Mastella riapre fino a 4 passaggi tra funzioni ogni 5 anni con vincoli territoriali: è forse la prima volta e sola che l’Anm applaude, mentre l’opposizione parla di resa alla magistratura.
2011, governo Berlusconi IV.
Si tenta col disegno di legge di Angelino Alfano: un progetto costituzionale per due Csm, carriere distinte e una corte disciplinare comune: ma cade col governo. È la prima volta che il principio viene messo nero su bianco in un testo costituzionale, ma la crisi finanziaria e la caduta del governo spengono tutto.
2017, governo Gentiloni.
L’Unione delle Camere Penali (gli avvocati) promuove una legge costituzionale d’iniziativa popolare con 75mila firme depositate. La proposta viene discussa in Commissione ma non arriva mai in aula.
2022, governo Draghi.
La Lega e il Partito Radicale riprovano la via referendaria con il quesito n. 3 che chiede di abolire il passaggio da giudicanti a requirenti. C’è solo il 20,9% di affluenza, niente quorum. Risultato politico nullo, ma la pressione sul Parlamento cresce.
2022, governo Draghi.
La legge 71/2022 di Marta Cartabia (ex presidente della Corte costituzionale) prevede un solo passaggio entro 9 anni, quindi una separazione di fatto senza toccare la Costituzione. È una separazione “interna” e un cambiamento tuttavia non strutturale.
2024-2025, governo Meloni.
La questione arriva al traguardo (forse) ed ecco il Ddl costituzionale di Carlo Nordio: due Csm (uno per i giudicanti e uno per i requirenti), carriere e concorsi separati, un’unica Corte disciplinare.
Il testo viene approvato dalla Camera (2024) e dal Senato (2025) e ora manca la seconda votazione: se non otterrà i due terzi, ci sarà un referendum confermativo. Sarebbe la prima volta nella storia repubblicana che gli italiani si pronunciano direttamente sulla struttura interna della loro magistratura.